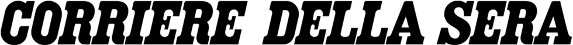Gastone - Le storie
di Marco Celati - Venerdì 09 Marzo 2018 ore 13:54

A chi appartengono le storie, di chi sono? Chissà. Di chi le vive, di chi le racconta o di chi le scrive? Chi le scrive le ruba a chi le racconta, chi le racconta a chi le vive. E chi le vive le ruba alla vita o a se stesso. Va a finire che le storie non appartengono a nessuno, sono solo di chi le legge.
A me non so se interessano le storie. Semmai m’interessa scriverle. Fare in modo che trasmettano sentimento e che di mio ci sia sopratutto come sono scritte. Che si capisca o, meglio, si senta come sono state scritte e, possibilmente, da chi. Perché scrivere ha lo stesso senso di viaggiare. Che non importa tanto la meta, quanto il viaggio in sé. E così è per la scrittura: non che non importi cosa descrive o racconta, ma è scrivere in sé la cosa veramente interessante. Difficile e appagante. E non è solo questione di contenuto e di forma, di significante e di significato: sono tutti sofismi, che è un modo più colto di dire segate. È che la forma è già il contenuto e viceversa. Almeno così è come la vedo io o, meglio, come la sento.
Avevo una buona storia, ne avevo scritto e finché si ha una storia da scrivere va ancora bene. Ma forse la terrò per me, perché così capisco che vuole chi me l’ha raccontata. È una questione di amicizia e di rispetto: per lui è una storia di famiglia. Ma forse sbaglio, non ci sono diritti d’autore sulle parole di un racconto, almeno finché sono voci e non scritti. E poi non c’è niente che si perda e si dimentichi più delle storie e dei ricordi di famiglia. E anche più delle amicizie. Ma è giusto così. E se la pubblicherò alla fine sarà proprio per amicizia perché presto sarà tardi anche nelle nostre vite. E perché la scrittura non mi è amica, non lo è mai stata, mi viene male ed è complicata, ma compagnia me ne fa. La compagna scrittura. Forse, magari, se me la ricordo o me la invento una storia, quella diventa solo mia e così posso metterla per scritto e farne un racconto che va per conto suo. Il nostro intero paese ci va, potrà andarci anche la mia storia.
Quando nel giorno dei morti i miei mi portavano al cimitero ciò che colpiva più la mia fantasia era l’immagine di mio nonno Gastone, su un loculo in alto: una foto ritoccata e sfumata che lo ritraeva, i capelli tirati indietro, con un’elegante giacca bianca e un papillon nero. Sembrava uno smoking, ho pensato a lungo che così fosse stato sepolto, in smoking. Avevo un nonno signore, il nonno paterno. Guardavo mio padre, suo figlio, che gli somigliava, gli staccava il viso, lungo e magro. Sembrava uno smoking, ma era una tenuta da cameriere: giacchetta e fiocchino. Poi me lo dissero, quando, più grande, in prima elementare, lo chiesi. Erano i vestiti da lavoro, i migliori che avesse e con cui lo avevano composto sul letto di morte. Faceva il cameriere da Pitschen.
I Pistchen erano una famiglia di origine svizzera. Avevano un palazzo costruito dall’architetto Bellincioni, all’angolo tra il Corso Matteotti e Via Lotti. Al piano terra di quel palazzo c’era una una pasticceria che nella bella stagione teneva i tavolini all’aperto. Lì lavorava il mio nonno Gastone. E ora mi spiegavo il perché dei pediluvi che mia nonna la sera, in cucina gli faceva, in una bacinella di acqua calda dentro cui metteva una sostanza che fumava, probabilmente bicarbonato, e poi lui con una lametta si toglieva i calli e a me sembrava una cosa raccapricciante e anche un po’ spaventosa. Specie una volta che si tagliò e l’acqua divenne rossa di sangue e io scappai in camera. Più grande, quando conobbi Petrolini, fantasticai sul nome del nonno: Gastone, Adone, la piega al pantalone, che sua mamma chiamava Tone per risparmiare il gas. Io risparmiavo sillabe e lo chiamava Gasto, come mi diceva la nonna, nonno Gasto. La nonna si chiamava Clelia, in toscano Crelia. I nomi ci piace storpiarli. Così era anche per i nonni materni: la nonna Isabella si chiamava Lisa. Tutti la chiamavano così, da sempre, subito dopo l’aulica iscrizione all’anagrafe. Un giorno che le dissi “nonna Isabella”, lei rispose “fritta in padella!”. Suo marito era Umberto, ma per lei e per tutti era Amberto. E per me, nonno Amberto. Loro stavano Forderponte, alle case popolari, erano il ramo comunista e contadino della famiglia. Venivano da Calcinaia, dove lavoravano la terra con i loro parenti e dove la mamma mi portava una volta all’anno, in bici, lungo l’argine e una volta ruzzolai di sotto, ma non mi feci nulla. Noi eravamo il ramo cittadino. Chi era di città si sentiva superiore, gli sembrava addirittura che “country nature” significasse contro natura. Ma le nostre storie e i nostri passati diversi si intrecciarono per l’amore che si vollero mio padre e mia madre. E così fu per molti, anche per il lavoro alla Piaggio che richiamò operai e impiegati dalle campagne in città, allo stabilimento di Pontedera.
Il nonno Gasto aveva fatto la grande guerra. Me lo raccontò, dopo, la nonna Crelia. Dentro le trincee, nell’acqua e nel fango, con scarpe di cartone e con vestiti che non riparavano dal freddo. Era stato lanciabombe e portaferiti. Una volta in trincea si scambiarono di posto con un compagno che subito dopo fu ucciso dal colpo di un cecchino austriaco. Il destino decide a piacere e a caso della vita e della morte. Lui tornò a casa con i polmoni malandati. Quando mi accompagnava a giocare alla Montagnola si fermava sulla panchina a riprendere fiato e una volta che persi fra le piante una pallina rossa, quanto penò a cercarla, ma non si trovò più. E quando saliva le scale di casa, in via Rossini, in centro città, respirava a fatica e poi gli veniva la tosse e portava un fazzoletto alla bocca. Bronchite asmatica, fumava. I polmoni sono sempre stati un problema per la nostra famiglia. Il babbo fumava sigarette a ripetizione: Nazionali esportazione, quelle verdi, o normali, quelle bianche con la nave blu. Con filtro o senza, tanto spesso e volentieri lo levava. Aveva i denti scuri, la piorrea e le dita ingiallite dalla nicotina. Quando smise era tardi ormai: enfisema e polmoni ricuciti, morì, così povero babbo. Peggio di come aveva vissuto: era una persona perbene. Aveva lavorato tutta la vita alla Piaggio, era divenuto impiegato, disegnatore; era impegnato nella politica, democristiano, moroteo, nel sindacato e nell’Azione Cattolica. La mamma l’aveva preceduto venti anni prima, molto giovane, quarantadue anni: un tumore alla pleura. Quando la riportarono a casa, alla fine, era irriconoscibile dalla bella donna che era stata. Non mi piace strappare lacrime, ma vorrei si capisse il dolore. Si erano amati nella vita. Al camposanto sono sepolti accanto e riposano insieme. Per sempre.
Continua
Pontedera, Febbraio 2018
Marco Celati