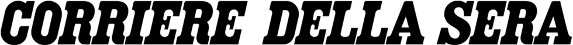Solitudine
di Nicola Belcari - Giovedì 27 Giugno 2024 ore 09:00

La solitudine intristisce l’esistenza. Essa ha più volti. Quella che deriva dall’io, o ego, è ineliminabile. L’uomo è solo nel profondo dell’essere, della coscienza di sé, e di fronte alla morte. Varie forme di socialità, rapporti interpersonali, amicizie e amori la possono attenuare, altre relazioni sociali, e sono molte quelle della contemporaneità, l’aggravano.
La parola ha un cattivo sapore, percepita com’è in un’unica accezione, quella negativa, richiama uno stato di sofferenza più o meno marcata, strisciante o accentuata. C’è invece una solitudine positiva, utile, anzi necessaria: è l’isolamento da distrazioni che serve per conoscere se stessi e costruire o perfezionare la propria personalità. L’allontanamento dagli altri così inteso non è un rifiuto del mondo, né misantropia. Chi ha fortificato se stesso è pronto per agire, stabilire attività e rapporti e un giusto “commercio” con il prossimo.
È questo il ritrarsi nel deserto, la Tebaide dei monaci medievali. Oggi, come allora, dal simbolo alla realtà, il modo più semplice di coltivare questo ritrarsi meditativo è il rimanere nella propria stanza (la cella del monaco). Oggi un ostacolo all’appartarsi, sottile, subdolo è dato dalla invasività dei media, capeggiati dalla tivvù (il più autoritario). Essi aboliscono le frontiere dell’intimità, contaminando lo spazio più caro ed esclusivo, e persino sacro; abbattono la barriera delle mura e la loro protezione dal mondo esterno con “giullari, cantori, ballerini per fuggire i pensieri della morte” come scrive Domenico Cavalca e contrastano la “contemplazione, la mistica solitudine, il pensiero di Dio” secondo le parole del Beato Giordano da Rivalto: “fuggire gente è fuggire nemici” (tentazioni e peccato) ché è bene evitare “la commistione con cose corruttibili e materie terrene”. Quel che s’invocava simbolicamente era la Tebaide, descritta nelle pitture (dell’Angelico o di Buffalmacco nel Camposanto Monumentale di Pisa, tra le più note), portata ad esempio dai predicatori del Trecento (e in particolare del convento domenicano di Santa Caterina di Pisa).
I media offrono un valore (pressoché) unico: il corpo di donna (gli altri sono dis-valori). Le immagini sono però il simulacro della realtà, l’idea di ciò che riproducono, sono il surrogato, senza sapore né sostanza, di ciò che rappresentano, inducono mortificazione e penitenze inconsapevoli e la sofferenza psichica autoinflitta prende il posto di cilici e flagelli. Da tema artistico quella bellezza è declinata nei modi più vari fino alla trivialità: dall’esibizione delle ballerine a giornaliste, o presentatrici, con le phisique da soubrette gambe-accavallanti fino agli estremi confini delle terre ignote e selvagge, annunciatrici delle previsioni metereologiche in balia di costanti alte pressioni a giudicare dai loro indumenti ridotti e svolazzanti, imprudentemente esposti ai venti dei quadranti meridionali. Sono la tentazione e il turbamento del monaco (il solitario, secondo l’etimo). Lì affonda, con senso di colpa, lo sguardo dell’indifeso telespettatore, voyeur suo malgrado. Sono i mostri delle tentazioni di sant’Antonio, nel labirinto dei cento canali tivvù e della rete di internet dove rimbombano urla, schiamazzi, pianti, risate, gemiti.
Nei tempi oscuri che ci sono toccati in sorte, stanchi dello sguardo degli altri che ci rivela le nostre insufficienze, bruttezze, limiti, miserie, potremmo credere un rifugio la realtà reificata dei media? È un abisso di traviamento senza salvezza né riscatto.
I moniti medievali possono far sorridere al vaglio della sensibilità moderna: si tratta però di cogliere nell’oggi una validità, oltre quella in parte sempre presente, soprattutto nella traduzione, nelle mutate forme, nella lingua e nella sostanza dell’attualità.
L’incontro con gli altri avviene nel chiuso di una stanza (nell’apparente sicurezza e incolumità personale) per immagini, alcune con corrispondenze reali, altre false, che hanno in comune, nel complesso, il significato e la conseguenza, nella vita di ognuno di noi, della perdita di contatti veri e del dominio di figure e fantasmi. intristisce l’esistenza. Essa ha più volti. Quella che deriva dall’io, o ego, è ineliminabile. L’uomo è solo nel profondo dell’essere, della coscienza di sé, e di fronte alla morte. Varie forme di socialità, rapporti interpersonali, amicizie e amori la possono attenuare, altre relazioni sociali, e sono molte quelle della contemporaneità, l’aggravano.
La parola ha un cattivo sapore, percepita com’è in un’unica accezione, quella negativa, richiama uno stato di sofferenza più o meno marcata, strisciante o accentuata. C’è invece una solitudine positiva, utile, anzi necessaria: è l’isolamento da distrazioni che serve per conoscere se stessi e costruire o perfezionare la propria personalità. L’allontanamento dagli altri così inteso non è un rifiuto del mondo, né misantropia. Chi ha fortificato se stesso è pronto per agire, stabilire attività e rapporti e un giusto “commercio” con il prossimo.
È questo il ritrarsi nel deserto, la Tebaide dei monaci medievali. Oggi, come allora, dal simbolo alla realtà, il modo più semplice di coltivare questo ritrarsi meditativo è il rimanere nella propria stanza (la cella del monaco). Oggi un ostacolo all’appartarsi, sottile, subdolo è dato dalla invasività dei media, capeggiati dalla tivvù (il più autoritario). Essi aboliscono le frontiere dell’intimità, contaminando lo spazio più caro ed esclusivo, e persino sacro; abbattono la barriera delle mura e la loro protezione dal mondo esterno con “giullari, cantori, ballerini per fuggire i pensieri della morte” come scrive Domenico Cavalca e contrastano la “contemplazione, la mistica solitudine, il pensiero di Dio” secondo le parole del Beato Giordano da Rivalto: “fuggire gente è fuggire nemici” (tentazioni e peccato) ché è bene evitare “la commistione con cose corruttibili e materie terrene”. Quel che s’invocava simbolicamente era la Tebaide, descritta nelle pitture (dell’Angelico o di Buffalmacco nel Camposanto Monumentale di Pisa, tra le più note), portata ad esempio dai predicatori del Trecento (e in particolare del convento domenicano di Santa Caterina di Pisa).
I media offrono un valore (pressoché) unico: il corpo di donna (gli altri sono dis-valori). Le immagini sono però il simulacro della realtà, l’idea di ciò che riproducono, sono il surrogato, senza sapore né sostanza, di ciò che rappresentano, inducono mortificazione e penitenze inconsapevoli e la sofferenza psichica autoinflitta prende il posto di cilici e flagelli. Da tema artistico quella bellezza è declinata nei modi più vari fino alla trivialità: dall’esibizione delle ballerine a giornaliste, o presentatrici, con le phisique da soubrette gambe-accavallanti fino agli estremi confini delle terre ignote e selvagge, annunciatrici delle previsioni metereologiche in balia di costanti alte pressioni a giudicare dai loro indumenti ridotti e svolazzanti, imprudentemente esposti ai venti dei quadranti meridionali. Sono la tentazione e il turbamento del monaco (il solitario, secondo l’etimo). Lì affonda, con senso di colpa, lo sguardo dell’indifeso telespettatore, voyeur suo malgrado. Sono i mostri delle tentazioni di sant’Antonio, nel labirinto dei cento canali tivvù e della rete di internet dove rimbombano urla, schiamazzi, pianti, risate, gemiti.
Nei tempi oscuri che ci sono toccati in sorte, stanchi dello sguardo degli altri che ci rivela le nostre insufficienze, bruttezze, limiti, miserie, potremmo credere un rifugio la realtà reificata dei media? È un abisso di traviamento senza salvezza né riscatto.
I moniti medievali possono far sorridere al vaglio della sensibilità moderna: si tratta però di cogliere nell’oggi una validità, oltre quella in parte sempre presente, soprattutto nella traduzione, nelle mutate forme, nella lingua e nella sostanza dell’attualità.
L’incontro con gli altri avviene nel chiuso di una stanza (nell’apparente sicurezza e incolumità personale) per immagini, alcune con corrispondenze reali, altre false, che hanno in comune, nel complesso, il significato e la conseguenza, nella vita di ognuno di noi, della perdita di contatti veri e del dominio di figure e fantasmi.
Nicola Belcari